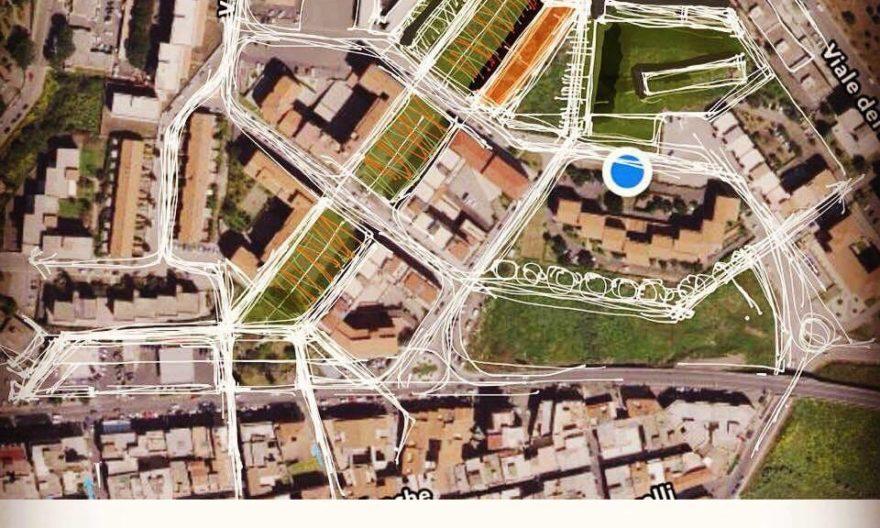
95047.it La città contiene città, altre, più complesse. Si lascia attraversare, resiste, si oppone, e sedimenta frammenti di storia. Si trasforma ancora prima di essere stata pensata nella sua nuova configurazione, seguendo modalità che apparentemente afferiscono al “caos”.
La città – che contiene la campagna – si oppone alla natura o forse è meglio dire che si confronta con la natura. Giace, si orienta e si connette con l’universo intero – fisico e metafisico.
La città, cosi come descritta contiene paesaggi. Tanti, trasversali, materiali e immateriali e in questo spazio culturale l’uomo la trasforma attraverso le sue azioni, i suoi pensieri, le sue procedure.
I paesaggi vivono di un equilibrio instabile e fragile. Apparentemente immutabili, modificano la loro forma/funzione seguendo tempi lenti (o cosi noi li percepiamo).
In pratica vivono in perenne “metamorfosi”. Se abbandonassimo un edificio, dopo alcuni decenni sarebbe invaso dalla natura. Gli alberi, le piante e gli animali “abiterebbero” con diritto il cadavere architettonico.
Se abbandonassimo la città avverrebbe la stessa cosa. Anche quando l’abbandono consiste solo nel non “pensarla” più. Si perché “pensare la città” significa averne una visione, immaginare la sua metamorfosi, accompagnare il fluido divenire di questo organismo attraverso piani, strategie, progetti.
Il nostro tempo registra però la contrapposizione di due “figure sociali” che snaturano la fisiologica evoluzione dell’organismo urbano: i ladri di terra e i cacciatori di popolo.
La politica – quella dell’indifferenza e della sufficienza – si è sottomessa a queste due “sette”, pressata dall’emergenza, dalla precarietà, dall’iperinformazione del web a buon mercato, dalla mancanza di risorse, fino a inglobarle in un unicum, che martella incessantemente la dignità della “civitas”. Credo che sia necessario analizzare con lucidità queste condizioni tumorali e ricostruire le ragioni che hanno determinato la bellezza delle città e che sembrano ormai perse generando per questo la disperazione di uomini e donne.
Credo che bisogna fare emergere la qualità dei processi, dei dispositivi e delle visioni, a partire da una nuova “umanità”. Un paesaggio immateriale, fatto di storia, di etica, di teologia, di politica che supporta una “volonta” collettiva, indirizzata, guidata e non plasmata.
Al centro il giardino planetario, l’uomo, la sua necessità di bellezza e felicità. La figura dell’architetto prometeico (C.Ratti, Open Source) forse ha bisogno di ridimensionare il suo “fare” verso una logica più cosmologica e partecipata. Ma qui la partecipazione deve essere meglio configurata per evitare “sindacalismi e consociativismi” a protezione di interessi localistici, di piccole lobby che preconfezionano idee. Il progetto/piano (inteso nella sua più rigida interpretazione etimologica) può, e deve sempre più, essere centrale rispetto alle metamorfosi tumorali dei paesaggi, inteso sempre più come un dispositivo processuale e multiculturale, evitando i “barabbismi”.
La visione di “paesaggio” o “paesaggi” fornisce un territorio progettuale multiscala e multirete che deve essere esplorato con grande delicatezza intellettuale, avendo sempre cura di “guardare” come gli artisti vedutisti, cubisti o futuristi, da parte a parte fin dentro le cose verso la sostanza delle cose. L’arte in questo senso ci aiuta a meglio interpretare lo spazio terreno e divino e ci pone come attori della metamorfosi (modifica di funzione e struttura) urbana, dalla scala strategica, passando per il progetto, fino alla determinazione delle regole derivate. Questo è l’impegno che dobbiamo alla collettività. Questa dobbiamo alle nostre città di pietra e cielo.
